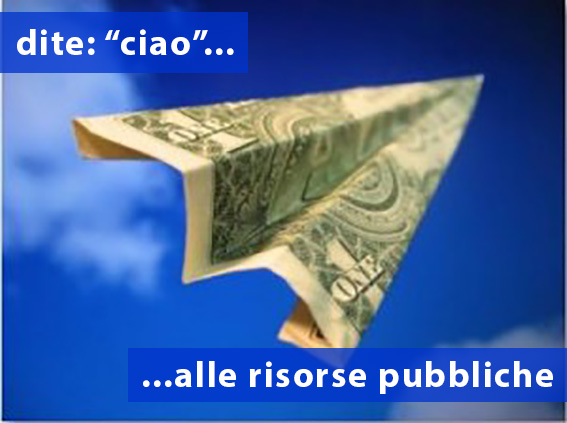E’ notizia di ieri che l’amministratore delegato di Alitalia avrebbe stilato un piano che prevede nuovi sacrifici per tutti i dipendenti con il fine “di risparmiare complessivamente fino a 100 milioni di euro”. Le indicazioni sul piano parlano infatti “di un mix di riduzione del numero di aerei impiegati e della messa in cassa integrazione per 1.100 dipendenti più la dolorosa chiusura di altrettanti contratti a tempo determinato: le tabelle indicano circa 260 piloti, 420 assistenti di volo e 450 impiegati”. E così, l’Alitalia privata (già privatizzata), salvata per la seconda volta in pochi anni da denaro pubblico, si avvia al suo piano di ristrutturazione aziendale consistente in tagli massicci di posti di lavoro e riduzione dell’attività.
Le note più dolenti della vicenda delle privatizzazioni, di cui abbiamo tracciato un quadro generale nel precedente articolo, si mostrano in tutta la loro crudezza nel flagrante paradosso del salvataggio pubblico di interessi privati senza nessuna contropartita in termini di sviluppo del paese o garanzie occupazionali.
Un paradosso che, sebbene sempre presente nella storia del capitalismo, tuttavia a partire dal 2007-2008, con l’inizio effettivo dell’attuale fase di profonda crisi economica, è letteralmente esploso. Negli ultimi cinque anni in tutto il mondo occidentale, tutti gli Stati, come noto, sono intervenuti massicciamente per salvare molte imprese e soprattutto moltissime banche dalla crisi. Così come avvento durante la crisi del 1929, lo Stato è entrato con enormi dosi di risorse nel capitalismo privato per salvare il sistema da un crollo a catena incontrollabile. Tuttavia, mentre durante la grande depressione del secolo scorso tale intervento di salvataggio del capitalismo inaugurò, seppur con ritmi e modalità diverse da paese a paese, una stagione incipiente (che ebbe poi il suo culmine nel secondo dopoguerra) di interventismo attivo del potere pubblico nelle dinamiche del capitalismo privato, oggi gli interventi assumono le sembianze esclusive di salvataggio di capitali privati senza contropartite e senza alcuna presa in carico da parte degli Stati dei destini della produzione.
La vicenda Alitalia è in tal senso emblematica. Nei suoi recentissimi sviluppi, che hanno ricalcato da vicino quanto già accaduto nel 2008, tale vicenda ha, ancora una volta, mostrato il fallimento economico e sociale della lunga stagione delle privatizzazioni e la miseria dell’attuale dibattito di politica economica e industriale egemone nel Paese.
Di fronte al precipitare degli avvenimenti nelle ultime settimane, che hanno visto venire al pettine i nodi della crisi finanziaria della compagnia aerea CAI Alitalia, erede della vecchia compagnia pubblica (privatizzata progressivamente a partire dai primi anni del 2000), due sono state le uniche campane risonanti nel dibattito pubblico, che ripetendo insistentemente il loro ritornello, hanno chiuso lo spettro delle alternative possibili a due sole soluzioni concepibili.
La prima soluzione, che chiameremo per semplicità “liberista”, ha sostenuto e sostiene che Alitalia andrebbe lasciata fallire, in quanto azienda non più competitiva sul libero mercato, incapace di far fronte alle migliori prestazioni di altre aziende concorrenti. A seguito del fallimento, bisognerebbe lasciare che il mercato faccia il suo lavoro e che l’acquirente più capace e più competitivo (estero o italiano che sia) acquisti la compagnia proponendo, senza clausole sociali, il proprio piano industriale ritenuto più profittevole.
La seconda soluzione, che chiameremo per semplicità “liberista assistita”, è stata quella che si è imposta nei fatti e che ha trovato la propria legittimazione ufficiale nell’idea che l’azienda andava soccorsa da un intervento dello Stato, al fine di salvaguardarne l’italianità e garantire la continuità operativa di un settore da alcuni definito come strategico.
Entrambe le soluzioni non discutono la centralità dei profili proprietari e delle scelte strategiche di politica industriale, ma rimettono al mercato e al capitalismo privato i destini della produzione e dello sviluppo del paese. In un caso, nella soluzione “liberista”, si porta il ragionamento teorico alle sue estreme conseguenze, dichiarando che l’azienda che fallisce deve seguire il suo corso trascinando con sé la sorte dei lavoratori e dell’indotto. Sarà il mercato stesso, in quest’ottica “idilliaca”, che provvederà a riallocare le risorse in maniera efficiente riassorbendo la manodopera respinta (al netto di una temporanea disoccupazione frizionale che non desterebbe preoccupazioni). Nell’altro caso si propone invece una soluzione che, in contraddizione con i presupposti teorici cui fa riferimento (il mito del capitalismo privato autosufficienze e performante), trova nell’intervento pubblico lo strumento di assistenza al profitto privato. Uno strumento (si dice) solo temporaneo per poi lasciare che il mercato faccia il suo lavoro.
I fautori delle due soluzioni hanno inscenato un grande scontro ideale ben riassunto dalla posizione espressa dal Ministro dei Trasporti Lupi, fautore della linea “interventista”: “Abbiamo lavorato per una soluzione liberale del caso Alitalia, i teorici del liberismo più sfrenato continuino pure con le loro teorie indifferenti alla realtà, noi preferiamo occuparci del bene comune”.
Nel concreto, si è trattato di far partecipare una società pubblica (Poste Italiane) ad un aumento di capitale finalizzato a ripagare i creditori dei debiti accumulati. Poste entrerebbero così con una quota azionaria (anche piuttosto consistente) nel capitale della compagnia per poi uscirsene (con ogni probabilità) non appena, ripulita la società dai debiti e accontentate le banche creditrici, qualche investitore privato (quasi sicuramente estero) mostri il proprio interesse a scalare la società acquisendone il pacchetto di maggioranza.
A cosa servirebbe dunque l’intervento pubblico attuato tramite Poste Italiane? Semplicemente a garantire i creditori dei loro crediti (le banche) e a salvare i capitali privati dei capitani coraggiosi che acquistarono la compagnia nel 2008. E chi erano questi “capitani-capitali coraggiosi” che salvarono l’italianità dell’impresa (salvo cederne comunque il 25% ad Air France già nelle prime fasi)?
Citando nell’ordine le quote di capitale più significative abbiamo: il Gruppo Riva tramite Riva Fire S.p.A. con poco più del 10% delle azioni (gli stessi signori che dopo aver acquistato la privatizzata Ilva, hanno avvelenato l’aria di Taranto e la salute dei suoi abitanti impunemente); il Gruppo Benetton tramite Atlantia S.p.A. con quasi il 9% (lo stesso gruppo che dopo aver delocalizzato tre quarti della propria produzione manifatturiera all’estero per abbassare il costo della manodopera, ha fatto shopping sui servizi pubblici privatizzati per garantirsi semi-rendite sicure a rischio zero); il gruppo bancario Intesa Sanpaolo S.p.A con un’analoga percentuale (ovvero uno dei due colossi bancari italiani che partecipano a numerose compagini azionarie di grandi imprese – alla faccia della reiterata richiesta di maggior separazione tra banche e imprese); e Roberto Colaninno tramite Immsi S.p.A. con il 7% (ovvero il capitano coraggioso della scalata della Telecom privatizzata nel 1999 e il proprietario della holding immobiliare Immsi, proprietaria a sua volta della Piaggio e di una società di cantieristica navale militare).
Ebbene tutti questi “capitani coraggiosi” (evidentemente avvezzi alle avventure imprenditoriali sorte dal banchetto festoso delle privatizzazioni italiane) uniti ad altri capitalisti privati possessori di quote minori, hanno “coraggiosamente” ottenuto l’aiuto di Stato avvenuto tramite la temporanea partecipazione al capitale dell’azienda pubblica Poste italiane.
Ancora una volta, come nel caso delle banche, lo Stato spende e spande per salvare i grandi capitalisti quando le loro enormi speculazioni non stanno funzionando più come essi vorrebbero.
Ma quale sarebbe l’alternativa all’oscena pratica della socializzazione delle perdite a seguito della privatizzazione dei profitti? Sarebbe forse quella suggerita dai liberisti oltranzisti del “libero mercato senza rigidità, senza vincoli e senza aiuti di Stato”? Quella per cui centinaia di migliaia di disoccupati sarebbero un semplice “fatto frizionale”? Quella per cui “ben vengano le multinazionali straniere piene di soldi a fare acquisti a basso costo in Italia”?
No, l’alternativa non è questa ed anzi, la soluzione liberista sarebbe in assoluto la più pericolosa e nociva per i lavoratori e per lo stato generale economico del paese che, sulla base della logica della “ferrea legge del mercato”, vedrebbe accelerare quel processo drammatico di deindustrializzazione e cessione delle proprie attività strategiche in pasto al pesce oggi più grande e feroce (ovvero, in questo caso, alle multinazionali straniere, statunitensi, tedesche e francesi in primis).
No, la soluzione ai fallimenti del mercato non è né uno Stato asservito al capitalismo privato né tanto meno “più mercato e più capitalismo privato senza Stato”. La soluzione è, tutto al contrario, un intervento pubblico attivo che sia in grado di riacquistare il controllo diretto o indiretto delle più importanti attività economiche, rilanciandole attraverso piani industriali di lungo periodo capaci di coniugare stabilità e qualità del lavoro, sviluppo e, nel caso di imprese a vocazione maggiormente commerciali, anche competitività internazionale.
Sì, perché il grande vantaggio dell’impresa pubblica è stato storicamente e può essere ancora oggi proprio la sua estrema flessibilità, la possibilità di perseguire obiettivi di natura diversa preservando i suoi caratteri fondamentali ed agendo nel contesto reale sulla base delle finalità principali imposte per via politica dal proprietario, ovvero lo Stato inteso come collettività.
Le privatizzazioni a grande scala verificatesi nell’ultimo ventennio non soltanto hanno privato lo Stato, ovvero tutti noi, di attività economiche che garantivano obiettivi sociali e di sviluppo rilevanti, ma hanno accelerato la repentina trasformazione dello Stato da mediatore di interessi contrapposti e conflitti sociali connaturati al capitalismo, a puro e semplice assistente dei profitti privati senza contropartite. Trasformazione facilitata da una cocente sconfitta di quelle forze politiche che si opponevano al capitalismo e da sconvolgenti mutamenti geopolitici (caduta del blocco socialista) che hanno demolito quell’equilibrio di forze grazie al quale fu possibile dare vita a quelle economie miste che hanno caratterizzato il capitalismo occidentale per oltre trent’anni dalla fine della seconda guerra mondiale.
Ed altri trent’anni ormai sono passati da quando quell’equilibrio e quel mondo è iniziato a vacillare e con esso tutta la struttura su cui si reggevano le economie miste, a partire dal ruolo centrale dell’impresa pubblica.
Da allora i governi italiani non attuano più politiche industriali intese come interventi pubblici di ampio respiro finalizzati ad orientare lo sviluppo del sistema economico nella direzione ritenuta socialmente migliore. A tali politiche si è sostituita sic et simpliciter la difesa di giganteschi interessi economici sempre più concentrati (che nella pratica e nell’ideologia dominante assume le vesti di politiche di tutela del libero mercato).
Tale difesa ad oltranza di una ristretta minoranza di milionari assume dimensioni di pura e palese sfacciataggine (che non può che suscitare profonda indignazione anche puramente istintiva) quando, mentre per praticare l’”austerità” si tagliano brutalmente i servizi pubblici essenziali per la popolazione, si versano contestualmente milioni di euro per il salvataggio di debiti privati considerati “troppo grandi per fallire”.
La soluzione a questa flagrante contraddizione (che potrebbe ingenuamente portare a pretendere un consequenziale “meno Stato”), dunque, non è certo il non interventismo voluto dagli economisti liberali. Una linea che non farebbe che esasperare tutti quegli enormi problemi causati proprio dalla libertà sempre più illimitata del capitalismo privato. E’ stata proprio la linea del non interventismo liberista, del resto, ad essere concausa di quella gigantesca redistribuzione di reddito regressiva (dall’alto verso il basso) avvenuta negli ultimi due decenni in tutti i paesi capitalistici occidentali.
Tutto al contrario, la soluzione al fallimento del capitalismo e delle imprese private è un intervento pubblico attivo, discrezionale, che rivendichi un ruolo di direzione dei processi economici e che imponga una presenza strategica rilevante della proprietà pubblica.
Occorre, dunque, spezzare la logica inservibile della falsa alternativa tra i due mali del libero mercato privo di vincoli e del libero mercato assistito, rivendicando la via dell’intervento attivo e della presa in carico diretta, da parte dello Stato, delle scelte produttive fondamentali a partire dai settori strategici.